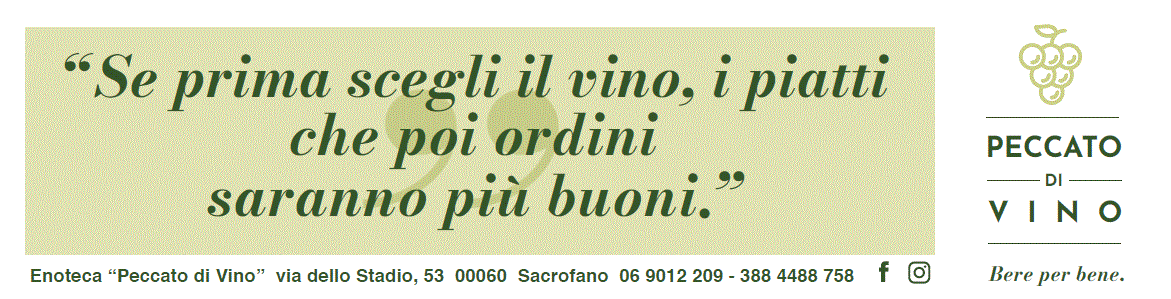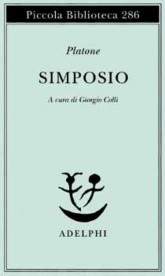Perché a Sacrofano c’è una piazza intitolata a Ugo Serata
Nativo di Sacrofano, dove ancora oggi vivono i parenti, Ugo Serata cadde a Cefalonia nell’eccidio della divisione Acqui
di Marco Ferri

Ugo Serata (1921-1943), per gentile concessione di Simonetta Santibelli, Nina Cirilli, Augusta Serata, Edoardo Serata
Carlo Azeglio Ciampi, che ha ricoperto la carica di presidente della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006, ha avuto un ruolo importante nel promuovere la memoria storica di quegli eventi che portarono alla morte di uomini come Ugo Serata. Durante il suo mandato, Ciampi ha infatti sottolineato l’importanza di ricordare le sofferenze e i sacrifici dei soldati italiani a Cefalonia e in altre località, evidenziando il bisogno di preservare la memoria storica per le future generazioni. Ugo, nato a Sacrofano il 27 giugno del 1921, a soli 22 anni subì una tragica fine durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare durante gli eventi che seguirono l’armistizio dell’8 settembre 1943 in Grecia, che l’esercito italiano aveva occupato insieme a quello tedesco e quello bulgaro. Serata era sottotenente del III Gruppo Artiglieria Contraerei della Divisione di stanza nell’isola di Cefalonia, dove avvenne uno dei più significativi episodi di resistenza dell’esercito italiano contro quello tedesco. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, le forze italiane a Cefalonia si trovarono in una situazione difficile, poiché i tedeschi, sia pure in inferiorità numerica (1800 contro 12000), intimarono la resa e la consegna delle armi. Il generale Gandin intavolò trattative per prendere tempo, che furono troncate il 15 settembre su ordine diretto di Hitler. Sull’isola la Germania riversò diversi battaglioni di rinforzo, mentre gli Stuka bombardavano indisturbati. Molti militari, tra cui Ugo Serata, si rifiutarono di arrendersi e combatterono per la loro dignità e per il ritiro delle forze italiane. Tuttavia, lo svantaggio della Acqui era incolmabile e il 22 Gandin annunciò la resa. Che non servì a nulla, perché Hitler aveva ordinato lo sterminio dei militari italiani: furono più di 5000 le esecuzioni sommarie, tra le quali quella di Ugo Serata, fucilato per non aver accettato di arrendersi. Chi riuscì a rompere l’accerchiamento si unì alla Resistenza greca, guadagnandosi ammirazione e rispetto. La morte di Serata è diventata simbolo della resistenza italiana e del sacrificio di coloro che si opposero al regime nazifascista. Persone come lui contribuirono a restituire dignità e credibilità al Paese. La sua storia è rappresentativa di molte esperienze dolorose e di coraggio vissute da soldati italiani durante la guerra. Il presidente Ciampi, un uomo che coltivava cultura e storia, ha sempre ritenuto fondamentale il riconoscimento delle vicende dolorose del nostro passato, in modo da non dimenticare e per costruire una società più consapevole. Le manifestazioni e le commemorazioni che si sono susseguite nel corso degli anni hanno contribuito a mantenere viva la memoria di ciò che accadde a Cefalonia e a riflettere sulle atrocità della guerra. Ecco perché Sacrofano ha una piazza intitolata a Ugo Serata.
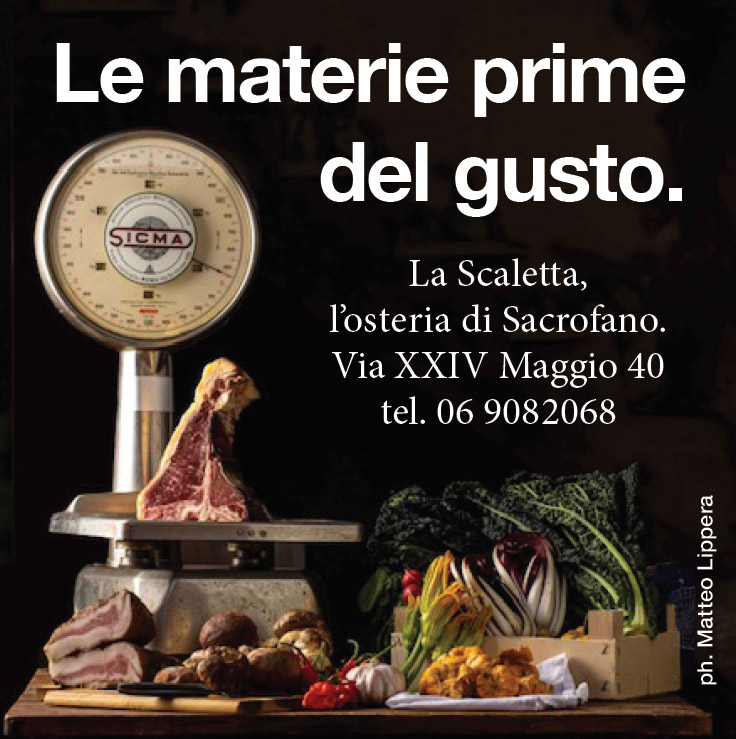
Così Sacrofano fece terra bruciata di Malborghetto
di Piero Santonastaso
 Poco prima della stazione di Sacrofano, sulla destra della Flaminia uscendo da Roma, c’è l’imponente edificio dal tristo nome di Malborghetto, epiteto nato alla fine del XV secolo sulle ceneri di una storia gloriosa. Tutto accadde per mano e volontà degli Orsini di Bracciano, che allora signoreggiavano su Sacrofano, da sempre fieramente in lotta con i Colonna. Ghibellini questi, Guelfi quelli, le due famiglie dal XIII secolo si contendevano il controllo non solo di Roma e del Lazio, ma anche delle sorti del papato. I Colonna giocavano nel campo degli imperatori germanici, mentre gli Orsini erano fieramente papalini ed entrambi si azzuffavano per il dominio delle più importanti castellanie intorno all’Urbe. Tra queste c’era un possedimento all’intersezione della Flaminia con la strada di collegamento a Veio. Lì, nel IV secolo, qualcuno aveva deciso di erigere un tetrapilo – edificio di forma cubica con una porta su ogni lato – per ricordare la vittoria ottenuta da Costantino su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio del 28 ottobre 312. Una sorta di fratello minore dell’arco di Costantino al Colosseo, per capirci. Secondo la vulgata è lì che l’imperatore, la notte prima della battaglia, avrebbe avuto la famosa visione della croce con la scritta In hoc signo vinces; altri individuano nel posto la sede dell’accampamento delle truppe di Costantino; altri ancora ritengono invece che lì Massenzio avesse schierato le sue truppe. L’esito della vicenda è noto: Massenzio era in superiorità numerica ma i suoi soldati da tempo non combattevano una battaglia vera, mentre Costantino aveva al seguito truppe ben addestrate e supportate da un consistente schieramento di barbari. Dopo un’iniziale prevalenza, Massenzio decise di arretrare verso il Tevere per attraversarlo, dimenticando però di avere a disposizione solo un precario ponte di barche, perché aveva fatto distruggere tra gli altri il Ponte Milvio. Il suo esercitò si ritrovò in trappola e lo stesso Massenzio annegò tentando la traversata. Fu dunque eretto il cosiddetto arco di Malborghetto, decisamente imponente: misurava circa 15 metri per 12 alla base ed era alto circa 18 metri. Ne hanno ricostruito le sembianze, nel 2006, i professori Alberto e Marco Carpiceci. Con il passare del tempo assunse sempre maggiore importanza fino a essere trasformato, nell’XI secolo, in una chiesa dedicata alla Vergine, intorno alla quale nel XIII secolo sorse un borgo fortificato, San Nicola dell’arco della Vergine, di proprietà della Basilica Vaticana. Lì si insediarono i Colonna e a quel posto, nel 1485, diedero l’assalto gli Orsini di Sacrofano, riducendolo in cenere. Quello che per tutti era il Borghetto, si trasformò in Borghettaccio, o Malborghetto, come lo conosciamo oggi. Il peggiorativo non è un unicum: nell’Agro romano ne esistono diversi altri esempi, come Malafede, Malagrotta, Malpasso. Serviva a identificare una zona come insicura e fonte di pericoli, soprattutto per la presenza di briganti. Un centinaio di anni più tardi lo speziale milanese Costantino Petrasanta rilevò e restaurò la proprietà, che con il tempo si trasformò in locanda e stazione di posta, fino a quando papa Pio VI a fine XVIII secolo abolì il servizio postale con Civita Castellana, decretando il nuovo declino per Malborghetto. Fino al 1982, quando fu rilevato dallo Stato e trasformato in antiquarium, riscoprendo le antiche strutture. (Info sulle visite nel sito della Soprintendenza Speciale di Roma.)
Poco prima della stazione di Sacrofano, sulla destra della Flaminia uscendo da Roma, c’è l’imponente edificio dal tristo nome di Malborghetto, epiteto nato alla fine del XV secolo sulle ceneri di una storia gloriosa. Tutto accadde per mano e volontà degli Orsini di Bracciano, che allora signoreggiavano su Sacrofano, da sempre fieramente in lotta con i Colonna. Ghibellini questi, Guelfi quelli, le due famiglie dal XIII secolo si contendevano il controllo non solo di Roma e del Lazio, ma anche delle sorti del papato. I Colonna giocavano nel campo degli imperatori germanici, mentre gli Orsini erano fieramente papalini ed entrambi si azzuffavano per il dominio delle più importanti castellanie intorno all’Urbe. Tra queste c’era un possedimento all’intersezione della Flaminia con la strada di collegamento a Veio. Lì, nel IV secolo, qualcuno aveva deciso di erigere un tetrapilo – edificio di forma cubica con una porta su ogni lato – per ricordare la vittoria ottenuta da Costantino su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio del 28 ottobre 312. Una sorta di fratello minore dell’arco di Costantino al Colosseo, per capirci. Secondo la vulgata è lì che l’imperatore, la notte prima della battaglia, avrebbe avuto la famosa visione della croce con la scritta In hoc signo vinces; altri individuano nel posto la sede dell’accampamento delle truppe di Costantino; altri ancora ritengono invece che lì Massenzio avesse schierato le sue truppe. L’esito della vicenda è noto: Massenzio era in superiorità numerica ma i suoi soldati da tempo non combattevano una battaglia vera, mentre Costantino aveva al seguito truppe ben addestrate e supportate da un consistente schieramento di barbari. Dopo un’iniziale prevalenza, Massenzio decise di arretrare verso il Tevere per attraversarlo, dimenticando però di avere a disposizione solo un precario ponte di barche, perché aveva fatto distruggere tra gli altri il Ponte Milvio. Il suo esercitò si ritrovò in trappola e lo stesso Massenzio annegò tentando la traversata. Fu dunque eretto il cosiddetto arco di Malborghetto, decisamente imponente: misurava circa 15 metri per 12 alla base ed era alto circa 18 metri. Ne hanno ricostruito le sembianze, nel 2006, i professori Alberto e Marco Carpiceci. Con il passare del tempo assunse sempre maggiore importanza fino a essere trasformato, nell’XI secolo, in una chiesa dedicata alla Vergine, intorno alla quale nel XIII secolo sorse un borgo fortificato, San Nicola dell’arco della Vergine, di proprietà della Basilica Vaticana. Lì si insediarono i Colonna e a quel posto, nel 1485, diedero l’assalto gli Orsini di Sacrofano, riducendolo in cenere. Quello che per tutti era il Borghetto, si trasformò in Borghettaccio, o Malborghetto, come lo conosciamo oggi. Il peggiorativo non è un unicum: nell’Agro romano ne esistono diversi altri esempi, come Malafede, Malagrotta, Malpasso. Serviva a identificare una zona come insicura e fonte di pericoli, soprattutto per la presenza di briganti. Un centinaio di anni più tardi lo speziale milanese Costantino Petrasanta rilevò e restaurò la proprietà, che con il tempo si trasformò in locanda e stazione di posta, fino a quando papa Pio VI a fine XVIII secolo abolì il servizio postale con Civita Castellana, decretando il nuovo declino per Malborghetto. Fino al 1982, quando fu rilevato dallo Stato e trasformato in antiquarium, riscoprendo le antiche strutture. (Info sulle visite nel sito della Soprintendenza Speciale di Roma.)
Leggo La Nuova Sacrofano perché…
“Leggo La Nuova Sacrofano perché vorrei che le mie figlie imparassero l’importanza di leggere i giornali”.

È partita la campagna “Sostieni anche tu La Nuova Sacrofano. Fai la tua donazione” che pubblica la foto col giornale in mano di ogni donatore che lo desideri. Scriveteci il motivo della vostra sottoscrizione su associazione@lanuovasacrofano.it
Le donazioni invece vanno fatte sul conto corrente intestato a La Nuova Sacrofano, utilizzando l’Iban IT69Y0832739390000000018349.
Fate anche voi come Alessandra Campanaro, sostenete La Nuova Sacrofano. Il nostro giornale è il vostro giornale.
Nel prossimo numero

Continuiamo a ragionare sugli strumenti delle politiche culturali. Daniela Ukmar ci racconta la sua esperienza come responsabile della Biblioteca Goffredo Mameli di Roma, biblioteca di prossimità nel quartiere Pigneto.
Per generare futuro c’è bisogno di cultura, curiosità e condivisione
Dopo i contributi delle assessore di Bracciano, Riano e Sacrofano, il dibattito attorno ai nuovi compiti delle politiche culturali delle istituzioni pubbliche prosegue con un intervento di Massimiliano Smeriglio, – Assessore alla Cultura del Comune di Roma
di Massimiliano Smeriglio
 Le politiche culturali determinano l’identità di una città, la raccontano nella sua interezza, nella sua verità, svelano il suo essere caleidoscopico e creano una consapevolezza che si trasforma in partecipazione. La cultura è un impulso. Ragionando in questa direzione, l’obiettivo di questo Assessorato è semplice ma ambizioso, poggia nell’idea di ripensare la cultura non come diversivo né come risposta ma come fondamento, perché sia un motore di crescita per tutti gli strati della cittadinanza. Abbiamo bisogno di cultura, di curiosità e abbiamo bisogno di condivisione collettiva per generare futuro e vivere Roma insieme, nella sua reale grandezza. Oltre il sipario del nostro maestoso patrimonio artistico che fa del Centro Storico di Roma Patrimonio dell’Unesco, ci sono le nuove energie, quelle contemporanee, diramate come vene cariche di idee in ogni quartiere, che raccolgono il testimone di una memoria artistica potente e la ripensano oggi con nuovi linguaggi, nuove forme, nuove percezioni. Per conoscerle e liberarle abbiamo aperto numerosi bandi, rivolti a ogni rete culturale, e abbiamo già raccolto la misura dell’entusiasmo con cui sono stati ricevuti perché sono arrivati oltre 800 progetti per il bando Open25, che grazie ai fondi del PNNR, intende promuovere eventi diffusi in vista del Giubileo. Nel bando è stato inserito l’indice di perifericità proprio perché pensiamo che le iniziative culturali, le performance, le avventure artistiche di questo tempo debbano arrivare ed essere trasmesse a ogni angolo di Roma e ritrovare cittadini e cittadine partecipi e coinvolti. Un altro dei progetti appena proposti è stato la call alle Università di Roma, pubbliche e private e agli istituti AFAM per Città Studio, progetto che intende portare la conoscenza fuori dalle mura accademiche e renderla visibile e accessibile. L’11 maggio del 2025 le piazze di 15 municipi, da Piazza Navona al Quarticciolo, saranno aule a cielo aperto in cui docenti renderanno disponibili lezioni divulgative su temi diversi, a seconda delle competenze, dalle scienze naturali a quelle sociali e umanistiche attraverso lezioni frontali e workshop. La cultura ci forma e ci rende liberi di scegliere chi essere, per questo avremo un’attenzione particolare alle generazioni giovani, agli studenti e le studentesse, perché abbiano tutte le opportunità che le Istituzioni possono offrire, a completamento e arricchimento dei percorsi di studio tradizionali. Già con Capodarte – la manifestazione per festeggiare il Capodanno, con oltre 100 iniziative diffuse, il programma ha dato ampio spazio ad artisti che dialogano fortemente con un pubblico giovane e i palchi sono stati messi a disposizione alle band e alle crew dei quartieri. Ragazzi e ragazze avranno libero accesso ai Musei, con la Mic Card, e Aule Studio a diposizione in ogni quartiere della città. Un impegno forte sarà anche rivolto ad attività culturali private, soprattutto alle librerie indipendenti che consideriamo poli culturali e di aggregazione per le comunità, in grado di fare rete e arricchire la vivacità culturale nei quartieri. Naturalmente queste, e altre iniziative, che intendono estendere il più possibile l’arte a Roma non escludono la celebrazione dei nostri spazi più iconici come luoghi in cui fruire le iniziative culturali. Non vogliamo soltanto animare le periferie ma vogliamo che i cittadini e le cittadine abbiano la possibilità di vivere il cuore di Roma agevolando le ovvie difficoltà che arrivarci comporta. Festival Letterature, per esempio, allo Stadio Palatino, si conferma un appuntamento atteso, al quale questo Assessorato continua a lavorare, favorendo però anche il pubblico più distante dal centro, mettendo a disposizione mezzi pubblici che offrono un servizio gratuito per portare in Centro Storico chiunque abbia desiderio di esserci.
Le politiche culturali determinano l’identità di una città, la raccontano nella sua interezza, nella sua verità, svelano il suo essere caleidoscopico e creano una consapevolezza che si trasforma in partecipazione. La cultura è un impulso. Ragionando in questa direzione, l’obiettivo di questo Assessorato è semplice ma ambizioso, poggia nell’idea di ripensare la cultura non come diversivo né come risposta ma come fondamento, perché sia un motore di crescita per tutti gli strati della cittadinanza. Abbiamo bisogno di cultura, di curiosità e abbiamo bisogno di condivisione collettiva per generare futuro e vivere Roma insieme, nella sua reale grandezza. Oltre il sipario del nostro maestoso patrimonio artistico che fa del Centro Storico di Roma Patrimonio dell’Unesco, ci sono le nuove energie, quelle contemporanee, diramate come vene cariche di idee in ogni quartiere, che raccolgono il testimone di una memoria artistica potente e la ripensano oggi con nuovi linguaggi, nuove forme, nuove percezioni. Per conoscerle e liberarle abbiamo aperto numerosi bandi, rivolti a ogni rete culturale, e abbiamo già raccolto la misura dell’entusiasmo con cui sono stati ricevuti perché sono arrivati oltre 800 progetti per il bando Open25, che grazie ai fondi del PNNR, intende promuovere eventi diffusi in vista del Giubileo. Nel bando è stato inserito l’indice di perifericità proprio perché pensiamo che le iniziative culturali, le performance, le avventure artistiche di questo tempo debbano arrivare ed essere trasmesse a ogni angolo di Roma e ritrovare cittadini e cittadine partecipi e coinvolti. Un altro dei progetti appena proposti è stato la call alle Università di Roma, pubbliche e private e agli istituti AFAM per Città Studio, progetto che intende portare la conoscenza fuori dalle mura accademiche e renderla visibile e accessibile. L’11 maggio del 2025 le piazze di 15 municipi, da Piazza Navona al Quarticciolo, saranno aule a cielo aperto in cui docenti renderanno disponibili lezioni divulgative su temi diversi, a seconda delle competenze, dalle scienze naturali a quelle sociali e umanistiche attraverso lezioni frontali e workshop. La cultura ci forma e ci rende liberi di scegliere chi essere, per questo avremo un’attenzione particolare alle generazioni giovani, agli studenti e le studentesse, perché abbiano tutte le opportunità che le Istituzioni possono offrire, a completamento e arricchimento dei percorsi di studio tradizionali. Già con Capodarte – la manifestazione per festeggiare il Capodanno, con oltre 100 iniziative diffuse, il programma ha dato ampio spazio ad artisti che dialogano fortemente con un pubblico giovane e i palchi sono stati messi a disposizione alle band e alle crew dei quartieri. Ragazzi e ragazze avranno libero accesso ai Musei, con la Mic Card, e Aule Studio a diposizione in ogni quartiere della città. Un impegno forte sarà anche rivolto ad attività culturali private, soprattutto alle librerie indipendenti che consideriamo poli culturali e di aggregazione per le comunità, in grado di fare rete e arricchire la vivacità culturale nei quartieri. Naturalmente queste, e altre iniziative, che intendono estendere il più possibile l’arte a Roma non escludono la celebrazione dei nostri spazi più iconici come luoghi in cui fruire le iniziative culturali. Non vogliamo soltanto animare le periferie ma vogliamo che i cittadini e le cittadine abbiano la possibilità di vivere il cuore di Roma agevolando le ovvie difficoltà che arrivarci comporta. Festival Letterature, per esempio, allo Stadio Palatino, si conferma un appuntamento atteso, al quale questo Assessorato continua a lavorare, favorendo però anche il pubblico più distante dal centro, mettendo a disposizione mezzi pubblici che offrono un servizio gratuito per portare in Centro Storico chiunque abbia desiderio di esserci.
Ho la convinzione che la cultura, nel suo senso più ampio, rappresenti lo strumento attraverso il quale i cittadini di un territorio vengono esposti a stimoli e a riflessioni continue, e che questo contribuisca alla costruzione di una collettività più consapevole e più libera. Ed è per questa collettività che stiamo lavorando.
Il teatro è una fabbrica
Cosa vuol dire gestire un teatro?
La testimonianza della direttrice artistica del Teatro San Giustino di Roma e capocomico della compagnia Signori chi è di scena! che il prossimo 9 marzo alle 17,00 metterà in scena “Dannazione donna” al Teatro Ilaria Alpi.
di Monica Ferri
 Il teatro è un luogo fisico meraviglioso, con un immenso potenziale. Ma è l’utilizzo che ne fanno le compagnie che lo rende uno spazio magico dove le parole del testo in scena risuonano potenti e segnano e arricchiscono l’anima degli spettatori. La vita dentro un teatro è intensa, fatta di sarte che cuciono, scenografi che costruiscono, registi che pensano, attori che cercano. È una fabbrica creativa con i suoi rumori, odori, colori. Spesso penso che il vero spettacolo magico siano le prove a ridosso del debutto. Il Teatro San Giustino di Roma, che abbiamo in gestione da vent’anni, si trova nel cuore del quartiere Alessandrino ed è frequentato da spettatori affezionati del quartiere, ma anche da numerosissimi spettatori che vengono da altre zone di Roma. Una cosa molto bella è sentir dire “Conosco il quartiere Alessandrino perché vado a vedere spettacoli al Teatro San Giustino”. Il direttore artistico di un teatro ha una grande e bellissima responsabilità culturale. Per me è come essere un trapezista che deve camminare in equilibrio su una corda tesa. La scelta dei titoli in cartellone, il criterio per selezionano le compagnie che verranno ospiti, il rispetto per il pubblico e per le sue aspettative, creano l’equilibrio giusto. Gestire uno spazio teatrale è davvero complesso e molto affascinante. Ci vogliono grande pragmatismo e bravi collaboratori. Innanzitutto, con un calendario alla mano si stabiliscono date, orari, giorni per l’intera stagione teatrale. Incluse le ore di prova e le ore di formazione. Ed è nella programmazione che si traccia la linea culturale dello spazio-teatro. Ma esiste anche la manutenzione che deve essere continua ed attenta. Un teatro esteticamente bello e tecnicamente funzionale aiuta tutti coloro che lo vivono (compresi gli spettatori) a restare concentrati sul proprio lavoro creativo.
Il teatro è un luogo fisico meraviglioso, con un immenso potenziale. Ma è l’utilizzo che ne fanno le compagnie che lo rende uno spazio magico dove le parole del testo in scena risuonano potenti e segnano e arricchiscono l’anima degli spettatori. La vita dentro un teatro è intensa, fatta di sarte che cuciono, scenografi che costruiscono, registi che pensano, attori che cercano. È una fabbrica creativa con i suoi rumori, odori, colori. Spesso penso che il vero spettacolo magico siano le prove a ridosso del debutto. Il Teatro San Giustino di Roma, che abbiamo in gestione da vent’anni, si trova nel cuore del quartiere Alessandrino ed è frequentato da spettatori affezionati del quartiere, ma anche da numerosissimi spettatori che vengono da altre zone di Roma. Una cosa molto bella è sentir dire “Conosco il quartiere Alessandrino perché vado a vedere spettacoli al Teatro San Giustino”. Il direttore artistico di un teatro ha una grande e bellissima responsabilità culturale. Per me è come essere un trapezista che deve camminare in equilibrio su una corda tesa. La scelta dei titoli in cartellone, il criterio per selezionano le compagnie che verranno ospiti, il rispetto per il pubblico e per le sue aspettative, creano l’equilibrio giusto. Gestire uno spazio teatrale è davvero complesso e molto affascinante. Ci vogliono grande pragmatismo e bravi collaboratori. Innanzitutto, con un calendario alla mano si stabiliscono date, orari, giorni per l’intera stagione teatrale. Incluse le ore di prova e le ore di formazione. Ed è nella programmazione che si traccia la linea culturale dello spazio-teatro. Ma esiste anche la manutenzione che deve essere continua ed attenta. Un teatro esteticamente bello e tecnicamente funzionale aiuta tutti coloro che lo vivono (compresi gli spettatori) a restare concentrati sul proprio lavoro creativo.

Cerbottana
Adesso è chiaro il perché di quella abitudine di urlare come ossessi nei bar e nei ristoranti. Confidano in San Biagio, protettore della gola e degli otorinola ringoiatri

No other land – finalmente un film che volevamo vedere
No other land
di Riccardo Tavani
Finalmente un film che volevamo vedere è stato proiettato a Sacrofano, al Teatro Ilaria Alpi.
È successo il 18 gennaio, grazie alla Regione Lazio, al MedFilm Festival, al Comune di Sacrofano e a La Nuova Sacrofano. Cento di questi giorni. Basel Adra, un ragazzo palestinese, con l’aiuto di Yuval Abraham, giovane giornalista israeliano, documenta la demolizione di case e l’allontanamento dei suoi abitanti da una dozzina di villaggi nella comunità Masafer Yatta in Cisgiordania. L’esercito israeliano attua tale esproprio e razzia di terre con la motivazione che là deve sorgere un’area di manovre militari per i carrarmati. Fanno la loro comparsa anche coloni armati di mitra. Uno di questi, protetto dai soldati, spara direttamente allo zio del ragazzo che fa le riprese. E – proprio per le continue documentazioni video e notizie che pubblica – anche questi è ricercato da esercito e polizia. Segue in questo il destino del padre, incarcerato numerose volte fin da giovane, perché attivista dei diritti palestinesi. Padre che fin da quando lui era bambino usava la cinepresa per riprendere le gite e altri momenti della vita familiare. Tutta la documentazione è realizzata con piccole videocamere e anche telefonini. Sembra di riascoltare la lezione del regista iraniano Jafar Panahi, perseguitato dalla dittatura teocratica scita, impartita nel suo film Taxi Teheran. Qui mostra come anche un’adolescente, quale la sua nipotina, può usare il telefonino per denunciare i soprusi d’ogni tipo in tutto il mondo. Ha quattro firme la regia di No other land, due palestinesi e due israeliane: Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor. E nonostante la frugalità tecnologica dei mezzi di ripresa, è entrato nella cinquina dei candidati al premio Oscar 2025 per i documentari, dopo aver vinto numerosi premi nel 2024, tra gli altri quelli di miglior documentario al 74° Festival di Berlino e agli European Film Awards. Tanto più attuale questo film dopo le dichiarazioni di Trump sulla deportazione in massa dei palestinesi da Gaza per fare della Striscia una riviera per facoltosi residenti. Durata 96 minuti
Ex Libris
a cura di M.F.
La bellezza
“Per esempio, di ciò che ora noi facciamo – bere, o cantare, o conversare – non vi è nulla che, come tale, sia bello: risulta tale, piuttosto, nell’azione, secondo il modo in cui questa viene compiuta. Tutto ciò, invero, se è compiuto in modo bello e retto, diventa bello, se invece non è compiuto rettamente, brutto. Così, dunque, non è vero che ogni amare e ogni Eros sia bello e degno di essere elogiato: lo è, piuttosto, l’Eros che incita ad amare in modo bello. L’Eros dell’Afrodite volgare, orbene, è in verità volgare, e porta a compimento ciò che capita: ed è quello che gli uomini dappoco amano. Costoro, anzitutto, amano le donne non meno dei fanciullo, amano i corpi piuttosto che le anime, ed infine, per quanto è loro possibile, amano le persone più stolte, mirando solo al compimento dell’atto, senza curarsi che ciò avvenga in modo bello o no”. (Platone, “Simposio”, Adelphi).
Un congedo
Parker non era morto il giorno successivo, 16 settembre, ma soffriva molto. La morfina non calmava più il dolore; non riusciva a mangiare né a bere. Non fu facile sistemarlo nella parte posteriore della camionetta. La pallottola, che lo aveva attraversato da parte a parte, gli aveva lacerato lo stomaco. Per fortuna la strada era abbastanza piana e le scosse erano sopportabili. C’era una luce chiarissima e il sole era abbagliante. Ora eravamo nel deserto, non privo di qualche cespuglio o arbusto, ma l’acqua, per l’uomo e il suo bestiame, era troppo lontana. Sotto un arbusto vidi un’enorme iena che continuava a girare su sé stessa, come fa un cane prima di dormire; un’ora dopo vidi una coppia di orici. Le pesanti bestie, grandi come torelli, dal manto bianco come la neve e dalle grandi corna ricurve, pascolavano tra i cespugli dall’odore dolciastro. Fermammo la camionetta per guardarli, perché nessuno di noi aveva mai visto animali del genere, né li rivedemmo. Aiutammo Parker ad alzarsi affinché anche lui potesse vederli. Ci sembrò importante che prima di morire li vedesse. (Vladimir Peniakoff, Private Army)
Vladimir Peniakoff (1897-1951) era un ufficiale britannico di origine belga, noto per aver fondato e comandato il Popski’s Private Army (PPA), un’unità di forze speciali britanniche attiva durante la Seconda guerra mondiale, particolarmente nel Nord Africa e in Italia. Il PPA era specializzato in ricognizioni, sabotaggi e azioni dietro le linee nemiche. Il suo libro Pri vate Army è un resoconto delle oper azioni del PPA e venne pubblicato nel 1950.
Pioggia d’autunno
a cura di Monica Maggi
Vorrei, pioggia d’autunno, esser foglia, abbandonarmi al tuo scrosciare, certa che non morrò, che non morrò, che solo muterò volto, sinché avrà la terra le sue stagioni, e un albero avrà fronde.
(Ada Negri)

Ada Negri è stata una scrittrice italiana. Di umili origini, insegnante, riuscì a imporsi nell’ambiente letterario e presso il pubblico. Collaborò a numerosi quotidiani e riviste e, nel 1940, fu accolta nell’Accademia d’Italia. Esordì con poesie di forma tradizionale e di ispirazione umanitaria, socialista e femminista (Fatalità, 1892; Tempeste, 1894; Esilio, 1914); in seguito scrisse versi di gusto dannunziano e di tono quasi diaristico (Il libro di Mara, 1919; I canti dell’isola, 1924); infine compose liriche che esprimono, con voce più raccolta e dimessa, una concezione cristiana della vita (Vespertina, 1930; Il dono, 1936). Sfocate e declamatorie sono le opere in prosa (Le solitarie, 1917; Stella mattutina, 1921; Sorelle, 1929), la cui nota più significativa è data dall’evocazione di una fanciullezza dolorosa, dalla descrizione di umili interni e di umane solitudini. Nel 2020 Mondadori pubblica Poesie e prose.
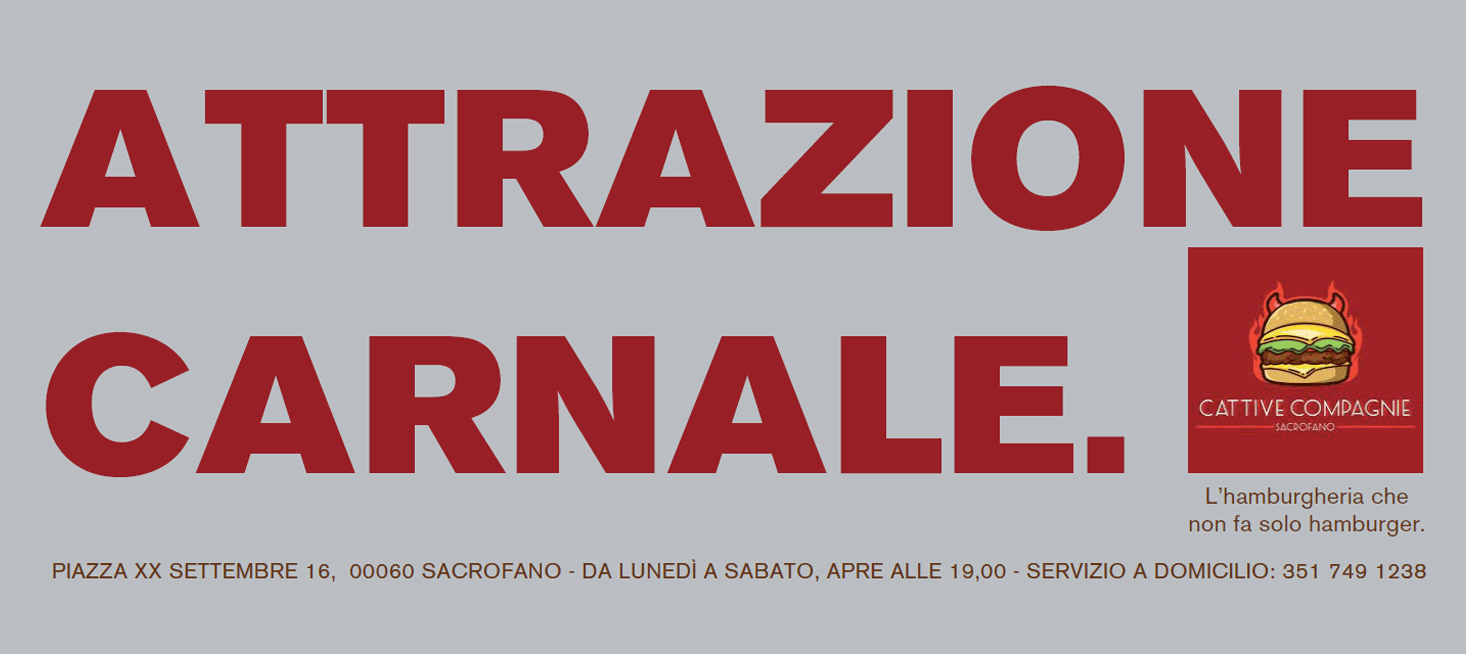
Che cosa bolle in pentola?
Ecco in cosa si differenzia la cucina romena da quella italiana
di Cristina Cotarta
Le cucine italiana e romena, pur condividendo alcune caratteristiche, sono profondamente diverse, riflettendo le loro storie e tradizioni culturali. Ecco un riassunto dei punti chiave. Dal punto di vista storico e geografico, la cucina italiana ha avuto contaminazioni romane, greche, arabe e normanne. La cucina regionale è ricca e variegata, con piatti come pasta, risotto e pizza. La cucina romena è stata influenzata dalle tradizioni balcaniche, ottomane, ungheresi e slave, con piatti rustici e abbondanti come carne di maiale, pollame e mamaliga. Per quanto riguarda gli Ingredienti principali, in Italia abbiamo pomodoro, olio d’oliva, pasta, formaggi e salumi; in Romania soprattutto carne (principalmente maiale), verdure, latticini, mamaliga e pane. Per i primi piatti, in Italia si cucinano pasta, riso e minestre con legumi e verdure fresche; mentre in Romania si servono ciorba (zuppa), spesso con carne e mamaliga. Il pane è sempre molto presente. Per i secondi piatti, l’Italia predilige grigliate, brasati, pesce e carne regionale; mentre in Romania abbiamo sarmale, mititei, carne arrosto e stufato, con mamaliga e verdure. In Italia i dolci e i dessert sono tiramisù, cannoli, panettone, crostata e gelato; in Romania: cozonac, papanasi, placinte. L’Italia vanta vini pregiati, con una forte cultura dell’abbinamento cibo-vino di derivazione regionale; in Romania troviamo vini autoctoni come Feteasca Neagra e Feteasca Alba, e la ?uica (distillato di prugne). Per quanto riguarda la cultura gastronomica, l’Italia è famosa per la qualità, la semplicità e il valore dei pasti come momenti di socialità. In Romania si ama la cucina rustica, legata alle tradizioni contadine, con piatti abbondanti e stagionalità al centro dei pasti familiari e festivi. In conclusione, le cucine italiana e romena differiscono soprattutto nei piatti e nei metodi di preparazione.  Mentre l’Italia privilegia piatti leggeri e variegati come pasta e pesce, la Romania è focalizzata su piatti più robusti, a base di carne e polenta. Entrambe riflettono forti identità ulturali e una passione condivisa per il cibo come momento di convivialità. La cucina italiana è molto apprezzata dai romeni. La pizza, la pasta, i formaggi e il gelato sono tra i piatti più amati, così come l’idea di pranzi e cene conviviali, che rispecchiano un po’ la cultura gastronomica romena. La cucina italiana è vista come una delle migliori al mondo e molti romeni che vivono in Italia, ma anche molte persone in Romania, soprattutto nelle grandi città, consumano regolarmente piatti italiani, sia nei ristoranti che preparandoli a casa. In Italia è possibile trovare gli ingredienti necessari per cucinare piatti tipici della cucina rumena. I principali ingredienti romeni, come carne di maiale, manzo, pollo, verdure fresche, latticini e spezie, sono facilmente reperibili in molti supermercati e negozi di alimentari. Tuttavia, per alcuni ingredienti più specifici, come certe varietà di formaggio rumeno (come il telemea o il brânză de burduf) o alcuni tipi di carne lavorata (ad esempio mici, i tipici salsicciotti rumeni), potrebbe essere necessario andare in negozi specializzati in prodotti Romeni che si trovano sempre più facilmente visto che la comunità romena in Italia è abbastanza radicata; quindi, non mancano le risorse per mantenere vive le tradizioni culinarie.
Mentre l’Italia privilegia piatti leggeri e variegati come pasta e pesce, la Romania è focalizzata su piatti più robusti, a base di carne e polenta. Entrambe riflettono forti identità ulturali e una passione condivisa per il cibo come momento di convivialità. La cucina italiana è molto apprezzata dai romeni. La pizza, la pasta, i formaggi e il gelato sono tra i piatti più amati, così come l’idea di pranzi e cene conviviali, che rispecchiano un po’ la cultura gastronomica romena. La cucina italiana è vista come una delle migliori al mondo e molti romeni che vivono in Italia, ma anche molte persone in Romania, soprattutto nelle grandi città, consumano regolarmente piatti italiani, sia nei ristoranti che preparandoli a casa. In Italia è possibile trovare gli ingredienti necessari per cucinare piatti tipici della cucina rumena. I principali ingredienti romeni, come carne di maiale, manzo, pollo, verdure fresche, latticini e spezie, sono facilmente reperibili in molti supermercati e negozi di alimentari. Tuttavia, per alcuni ingredienti più specifici, come certe varietà di formaggio rumeno (come il telemea o il brânză de burduf) o alcuni tipi di carne lavorata (ad esempio mici, i tipici salsicciotti rumeni), potrebbe essere necessario andare in negozi specializzati in prodotti Romeni che si trovano sempre più facilmente visto che la comunità romena in Italia è abbastanza radicata; quindi, non mancano le risorse per mantenere vive le tradizioni culinarie.
Diferențe și asemănări între tradițiile culinare italiene și românești
Cristina Cotarta
Bucătăria italiană și românească, deși împărtășesc unele caracteristici, sunt profund diferite, reflectând istoriile și tradițiile lor culturale. Iată un rezumat al punctelor cheie: Influență istorică și geografică: Italia: influențe romane, grecești, arabe și normande. Bucătărie regională bogată și variată, cu mâncăruri precum paste, risotto și pizza. România: tradiții balcanice, otomane, maghiare și slave, cu preparate rustice și consistente precumcarne de porc, pasăre și mămăligă. Ingrediente principale: Italia: roșii, ulei de măsline, paste, brânzeturi și mezeluri. România: Carne (în special carne de porc), legume, produse lactate, mămăligă și pâine. Primele feluri de mâncare și supe: Italia: Paste, orez și supe cu leguminoase și legume proaspete. România: Ciorbă, adesea cu carne și mămăligă. Pâinea este, de asemenea, foarte prezentă. Felul doi : Italia: Carne la grătar, înăbușită, pește și carne regională. România: Sarmale, mititei, carne prăjită și înăbușită, tocanita cu mămăligă și legume.
Dulciuri și deserturi: Italia: Tiramisu, cannoli, panettone, tartă. România: Cozonac, papanasi, plăcinte. Vinuriși băuturi: Italia: Vinuri fine precum Chianti, Barolo, Prosecco, cu o puternică cultură a asocierii mâncării șivinurilor. România: Vinuri autohtone precum Fetească Neagră și Fetească Albă și țuică (distilat Cultura gastronomică: Italia: Bucătărie renumită pentru calitatea, simplitatea și valoarea meselor ca momente de socialitate. România: Bucătărie rustică, legată de tradițiile țărănești, cu preparate abundente și sezonalitate încentrul meselor de familie și festive. Concluzii: Bucătăriile italiană și românească diferă în principal în ceea ce privește preparatele șimetodele de preparare. În timp ce Italia preferă mâncărurile ușoare și variate, cum ar fi pastele șipeștele, România se concentrează pe mâncăruri mai robuste, pe bază de carne și mămăligă. Ambelereflectă identități culturale puternice și o pasiune comună pentru mâncare ca moment de convivialitate. Bucătăria italiană este foarte populară printre români.
L’IIS via Emery, da Saxa Rubra verso l’Europa con Erasmus+
Una buona notizia per gli studenti di Sacrofano che vanno alle superiori
di Federica Andreoli
 L’IIS via Emery 97 è stato accreditato anche per l’anno scolastico 2024-2025 per un progetto europeo Erasmus+. Questa volta ha partecipato a un progetto di breve durata KA122 cofinanziato come sempre dall’Unione Europea. Ricordiamo che l’IIS Emery partecipa al programma Erasmus+ ormai da decenni e dà la possibilità sia a studenti che a docenti di partecipare a tali progetti. Quest’ultimo, dal titolo “EULab: A journey towards Transition, Democracy and Inclusion”, offre ai docenti dell’istituto Emery l’opportunità di partecipare ad attività di jobshadowing presso l’Institut de Gurb in Catalogna, Spagna. Ciò ha rappresentato un’esperienza formativa fondamentale per i docenti dell’Emery, offrend o loro la possibilità di confrontarsi con una realtà educativa diversa, di apprendere nuove metodologie didattiche e di riflettere su come migliorare la propria pratica professionale. In particolare, ci si è focalizzati su come incentivare la sensibilità ambientale nelle aule incoraggiando gli studenti a discutere di questioni green. Oggi più che mai, l’educazione ambientale ricopre un ruolo essenziale all’interno delle aule scolastiche. Insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, la differenza tra energie rinnovabili e non rinnovabili, le ragioni che determinano l’inquinamento ambientale e come ridurre gli sprechi, diventa necessario per poter formare dei cittadini responsabili e in grado di agire per il bene di tutta la comunità. Questa mobilità è stata essenziale in quanto ha permesso ai docenti dell’Emery di osservare nuove idee e strumenti da applicare nelle proprie classi e conseguentemente di avviare un cambiamento positivo in tutto l’istituto influenzando positivamente anche gli studenti e le loro famiglie.
L’IIS via Emery 97 è stato accreditato anche per l’anno scolastico 2024-2025 per un progetto europeo Erasmus+. Questa volta ha partecipato a un progetto di breve durata KA122 cofinanziato come sempre dall’Unione Europea. Ricordiamo che l’IIS Emery partecipa al programma Erasmus+ ormai da decenni e dà la possibilità sia a studenti che a docenti di partecipare a tali progetti. Quest’ultimo, dal titolo “EULab: A journey towards Transition, Democracy and Inclusion”, offre ai docenti dell’istituto Emery l’opportunità di partecipare ad attività di jobshadowing presso l’Institut de Gurb in Catalogna, Spagna. Ciò ha rappresentato un’esperienza formativa fondamentale per i docenti dell’Emery, offrend o loro la possibilità di confrontarsi con una realtà educativa diversa, di apprendere nuove metodologie didattiche e di riflettere su come migliorare la propria pratica professionale. In particolare, ci si è focalizzati su come incentivare la sensibilità ambientale nelle aule incoraggiando gli studenti a discutere di questioni green. Oggi più che mai, l’educazione ambientale ricopre un ruolo essenziale all’interno delle aule scolastiche. Insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, la differenza tra energie rinnovabili e non rinnovabili, le ragioni che determinano l’inquinamento ambientale e come ridurre gli sprechi, diventa necessario per poter formare dei cittadini responsabili e in grado di agire per il bene di tutta la comunità. Questa mobilità è stata essenziale in quanto ha permesso ai docenti dell’Emery di osservare nuove idee e strumenti da applicare nelle proprie classi e conseguentemente di avviare un cambiamento positivo in tutto l’istituto influenzando positivamente anche gli studenti e le loro famiglie.
Nella foto le docenti dell’IIS via Emery 97. Da sinistra: Menichelli, Andreoli, Martino e Caporuscio a Girona, Cataluña, Spagna
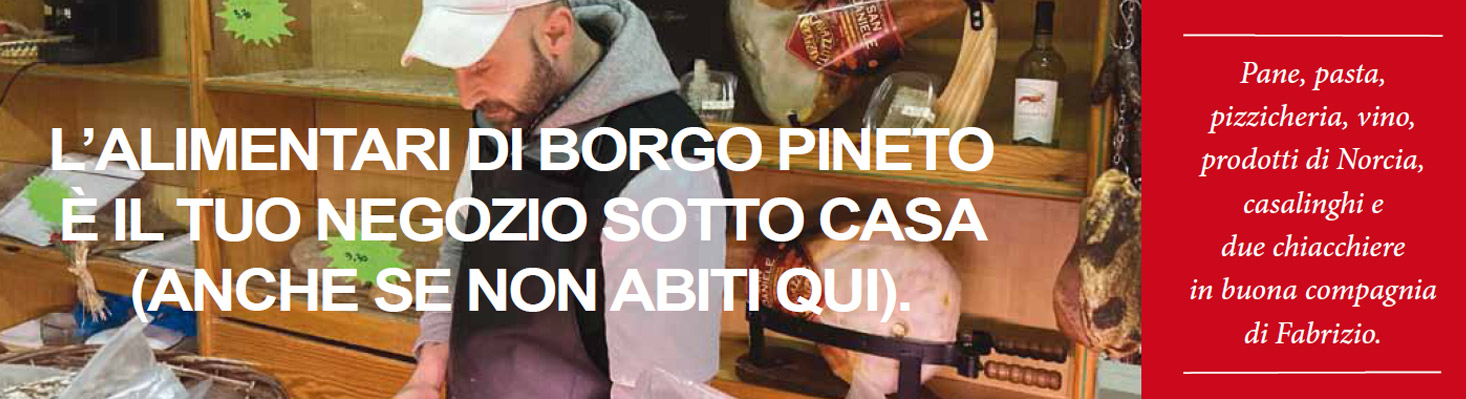
Quella tela restaurata nella Chiesa di San Biagio
Alessia Felici, restauratrice che vive a Sacrofano, donò il lavoro di rinascita della tela nel 2020, in occasione della celebrazione del Giubileo dei suoi cinquant’anni
di M F

(Foto di Romeo Marcori)
Il quadro è di Enrico Bartolomei (Foligno 1815-Roma 1901), pittore e decoratore con forti influenze del purismo preraffaellita. Il dipinto fu eseguito nel 1846, come si evince dall’iscrizione che reca anche la firma autografa dell’autore. In realtà fu ritrovato nella Chiesa di Santa Maria, di cui esistono ancora i ruderi, dopo che fu abbandonata, sconsacrata, fino a che le tegole e i mattoni non furono utilizzate per costruire e restaurare le case del Borgo di Sacrofano. La chiesa in cui la Madonna del Bartolomei fu collocata in una navata, fu probabilmente edificata dalla famiglia Santi, latifondisti di una vasta area che andava da Campagnano fino al porto di Capena, sul Tevere. Tutto fa pensare che il dipinto fosse di loro proprietà. Dunque, in questa area dell’Etruria meridionale, la chiesa di Santa Maria si trovava al centro di un crocevia di percorsi su cui si muoveva il bestiame, che trovava ricovero nelle grandi grotte limitrofe. La destinazione di quelle terre passò dalla proprietà terriera dei Santi all’istituzione delle aree demaniali, dedicate agli usi civici per poi venir istituzionalizzate nei possedimenti dell’Università dei Possedimenti di Bestiame di Sacrofano. Attualmente la madonna di Bartolomei è collocata nella Chiesa di San Biagio, nel centro di Sacrofano. La Chiesa parrocchiale di San Biagio ha promosso, in occasione del Giubileo 2025, anche la valorizzazione delle altre due chiese: la Chiesa di San Giovanni e la chiesa della Madonna della Grotta, entrambe visitabili il sabato e la domenica, grazie all’impegno di volontari. La tela rappresenta la Madonna che nell’atto dell’Ascensione protegge Sacrofano, il cui centro abitato è collocato nel lato più basso del quadro. Il paese è dipinto come se fosse, da un lato preda di un temporale, e dall’altro, irradiato da un raggio di sole. Il restauro, dice Alessia Felici, è stato un lavoro molto delicato, poiché le condizioni in cui la tela è stata prima rinvenuta nella Chiesa di Santa Maria e poi ricollocato a San Biagio non erano certo ottimali per la conservazione. Quest’opera, che non ha solo un valore artistico intrinseco, ma che rappresenta anche, – come abbiamo cercato di raccontare -, alcuni degli aspetti storici dell’evoluzione del territorio è visibile dalle 8 alle 17 di tutti i giorni presso la Chiesa di San Biagio, a Sacrofano.
Uno spettacolo per capire l’8 marzo
Vi si alternano commedia e farsa, invettiva, thriller e dramma, nei quali passano in scena figure femminili che rappresentano la realtà sociale e lavorativa delle donne in Italia
di Raffaello Fusaro
Winnie la protagonista di Giorni felici è sepolta viva in un mucchio di sabbia in cui affonda. Un piccolo ombrellino la ripara dalle intemperie. Non ammette a sé stessa di trovarsi in una situazione tremenda. Lei si proclama felice. Va avanti. Ha la borsetta, lo specchio, la spazzolina e un marito che ammorba con il suo estenuante bla bla bla. Ha una piccola pistola con la quale potrebbe farla finita, ma il gesto rappresenterebbe una sconfitta. Per questo i suoi giorni tutti uguali… sono giorni felici. Beckett metteva in scena le assurdità dell’esistenza in cui siamo impantanati e l’attaccamento alla vita che non molla anche in condizioni estreme. La protagonista era cosciente o estremamente incosciente? La domanda non cambia il suo comportamento. Erano gli inizi degli anni 60. La contestazione primaverile non era scesa del tutto nelle strade. Le idee borghesi e il vecchio mondo sembravano affondare nelle sabbie mobili. In quegli anni la pillola anticoncezionale, fortemente voluta dalle donne, veniva lanciata sul mercato europeo. Oggi, dopo lotte e prese di coscienza, molti valori che diamo per acquisiti in realtà non sono condivisi da tutti. Sono negati dietro sottili discriminazioni che impantanano anche la nostra epoca. Si vorrebbe la parità definitiva ma ci scontriamo ancora in estenuanti discussioni sul genere da usare nelle professioni. Vera Gheno, sociolinguista, sottolinea che si utilizzavano già nell’antichità i nomina agentis al femminile. Nonostante questo, la grazia e la cura nell’utilizzo delle parole appaiono ancora un po’ distanti. In Dannazione donna le parole delle protagoniste sono pensate. A volte l’autore le utilizza come slogan in difesa della persona, altre sintetizzando i dati odierni in pensieri che fanno riflettere intorno alla parità di genere. Durante la performance di Monica Ferri ho badato alle reazioni del pubblico. La protagonista, anzi coprotagonista con altre 8 sé stesse diverse per anagrafe e ritmi, riceve applausi, suscita risate e commenti in una forma di teatro partecipata. Le risposte degli spettatori ricordano espressioni di teatro sociale che interrogano prima di dar risposte. Siamo nel presente. Il tema del monologo attiene le diseguaglianze delle donne nel mondo del lavoro, economiche e di ruolo. La storia è ambientata in una grande azienda. In 8 quadri 8 donne sono interpretate da una sola attrice. La recitazione di Monica è densa, ricca e complessa, ironica, straniata e naturalistica un attimo dopo, proprio come complicati sono i ruoli delle donne nella società. Dalla signora delle pulizie alla stagista, dall’impiegata alla testimonial passando per la precaria, si recita su e giù lungo la rampa dei ruoli. L’attrice diventa giornalista e padrona di casa fino all’amministratrice delegata di un’importante azienda facendo pensare a quante scene si devono interpretare e quanti caratteri assumere per lavorare. In Italia, nazione che è sopra la media Ue per presenze femminili nei consigli di amministrazione, solo il 4% degli amministratori delegati è una donna! Alcune vivono ruoli sottovalutati, altre interpretano ruoli imposti dalle circostanze, altre accettano posizioni dentro aziende che rifiutano la maternità (o meglio preferiscono gentilmente scelte più economiche). Al termine della pièce le interpretazioni annullano il concetto stesso di ruolo in uno che li riassume tutti: quello dell’attrice che li interpreta. La Ferri toglie le maschere dell’artista. Con la sua capacità analitica di interpretazione ritorna soltanto una donna che testimonia tutte le donne.
Una riflessione a proposito della linea editoriale
Ci siamo chiesti perché I lettori ci chiamano affettuosamente “il giornalino”. È un vezzeggiativo che ci dice che siamo entrati nelle abitudini della comunità? In effetti, siamo un giornale che non denuncia quello che va male, mette in risalto ciò che c’è di buono. Quello che non funziona o che funziona male ha molte cause, che spesso vengono sovraccaricate di responsabilità soggettive. Dare la colpa va di moda, lo fanno tutti i giorni i social, i talk show. Troppo spesso denuncia e inchiesta vengono confuse, come le carte che il baro fa finta di aver mischiato correttamente, per nascondere l’inganno, indicare un nemico è infatti un trucco retorico vecchio come il mondo. Dare la colpa è comodo, ci scarica della responsabilità di approfondire le questioni, ci induce a facili e improvvisate prese di posizione, come fare il ruttino e credere di aver digerito. Abbiamo scelto un’altra strada. Forse più accidentata, magari in salita, ma più promettente e impegnativa: cercare e raccontare quello che funziona, perché funzioni ancora meglio, perché crei fiducia che le cose possono migliorare, perché le buone pratiche stimolino la qualità delle persone, e di conseguenza promuovano le qualità che il nostro territorio ha e può esprimere. Ci prefiggiamo di parlare a ogni lettore perché si senta parte di una comunità, che insieme può superare le difficoltà, mettendo a fuoco le soluzioni non astrattamente, ma confrontandole con il modo in cui i problemi sono stati risolti da altri soggetti, in altre realtà. Un giornale di comunità è un laboratorio di ricerca, che coinvolge chi lo scrive e chi lo legge in una visione concreta e realistica delle potenzialità che si stanno esprimendo e di quelle che ancora non riescono a uscire dal guscio. Le cose cambiano quando la consapevolezza prende il posto della sfiducia, del “tanto si è sempre fatto così”. Perché sapere cosa succede di nuovo è meglio del “tanto non cambia niente”. Quello che il giornale si prefigge è proporre la visione delle cose da un altro punto di vista, un punto di vista condiviso tra chi scrive e chi legge La Nuova Sacrofano.
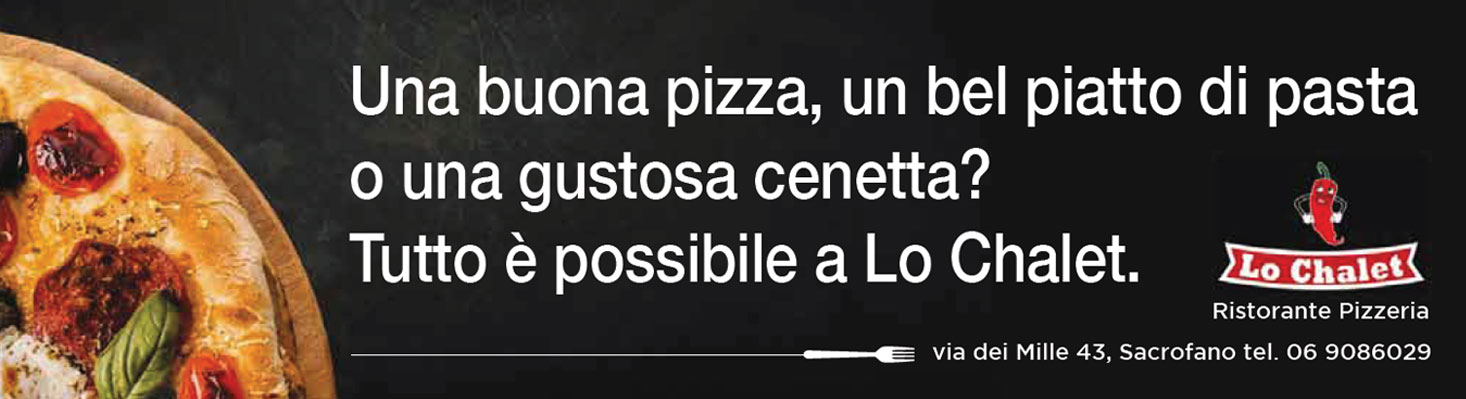
Quando al cane muore il padrone, quando al padrone muore il cane

di Icilio Tomassetti, veterinario
La vita professionale del veterinario è fatta di tanti momenti, le soddisfazioni ed i successi si alternano con i fallimenti o l’amaro sapore di un risultato non raggiunto, al pari, mi sento di dire, con tutte le altre professioni che vengono vissute con partecipazione. Una delle circostanze emotivamente più coinvolgenti è la perdita dell’animale da parte del proprietario: in qualunque modo essa avvenga ed indipendentemente dall’età, rappresenta un uragano di tristezza, rabbia, frustrazione. Il proprietario si abbandona a dubbi che prepotentemente pervadono la propria mente: “avrei potuto fare di più?”, “ma se lo avessi portato prima?”, “è stata la giusta decisione?”. In questa situazione per ogni domanda non basterebbero mille risposte a placare la disperazione, ed è in questo preciso istante che noi veterinari dobbiamo cambiare abito, diventare l'”amico” più intimo per meglio capire come consolare, aiutare, stare vicino, ma allo stesso tempo nascondere la nostra di sofferenza: spesso ci si unisce in un forte abbraccio. E poi, accade anche il contrario: è il cane a perdere il padrone. Per i nostri animali d’affezione il proprietario è veramente tanto se non addirittura tutto: è l’amico, il compagno di giochi, il dispensatore di coccole, colui che lo accudisce, colui che gli fornisce le cure. Spesso gli animali che perdono questo punto di riferimento cambiano il loro carattere, divengono meno gioiosi e giocosi, meno reattivi alle sollecitazioni esterne cioè apatici. Spesso anche l’appetito si modifica, in alcuni casi diminuisce, in altri aumenta diventando fonte di piacere sostitutiva, in altri casi emettono vocalizzazioni lamentose. Ci sono esempi, stupendamente rappresentativi del rapporto uomo-animale, come quando il cane quotidianamente raggiunge la sede di sepoltura del proprietario, altri, estremi, in cui gli animali rifiutano completamente il cibo fino a lasciarsi morire
La trippa
a cura di A I
Per sei persone
- si prende un chilo e mezzo di trippa,
- si risciacqua abbondantemente
- poi si ritaglia in pezzi piuttosto grandi
- si mette a cuocere in acqua fredda in una grossa pentola con sale, cipolla, sedano e carota.
- Si schiuma la pentola con cura e si lascia bollire su fuoco moderato fino a cottura completa, che avverrà in circa cinque
- Quando la trippa è cotta si taglia in fettucce larghe circa un dito e si insaporisce nel sugo(*), lascandola sobbollire per circa mezz’ora.
- Si verifica se sta bene di sale e si serve con parmigiano grattato nel quale si saranno tagliuzzare foglioline di mentuccia
- In tavola ognuno condirà la trippa con una cucchiaiata o due di questo parmigiano
aromatizzato, che è obbligatorio e costituisce la caratteristica della trippa alla romana, anche se una volta “i romani de Roma” la condivano col pecorino. (*) Ci sono due modi di preparare il sugo. Il “sugo finto” è un sugo fatto con soffritto di cipolla, sedano e carota, con l’aggiunta di un etto di lardo o grasso di prosciutto. Il “sugo d’umido” prevede una preparazione più elaborata. Si cuoce a fuoco lento lardo e bocconcini di manzo tritati, con aglio e prezzemolo. Un tempo si aggiungeva lo strutto. Quando il tutto era diventato una salsa, allora si aggiungeva un tritato di cipolla, sedano e carota, sale, pepe e chiodi di garofano. Quando tutto è cotto e sembra una poltiglia, si aggiunge
alla cottura mezzo bicchiere di vino rosso, poi il pomodoro, e acqua. Si cuoce ancora per un’ora prima di mettere la trippa a insaporire nel “sugo d’umido”.

L’Italia è diventato un Paese incerto e preoccupato?
È l’istantanea degli italiani scattata da due sondaggi dell’Ufficio Studi Coop condotte a dicembre 2024; la prima su un campione rappresentativo della popolazione italianan e la seconda sulla community di esperti del portale italiani.coop. Non è difficile trovare conferme sentendo le persone parlare tra loro nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, nei luoghi pubblici frequentati ogni giorno dagli abitanti di Sacrofano. Stretti tra il moltiplicarsi di guerre e conflitti, l’inasprirsi delle tensioni internazionali, l’aggravarsi dell’emergenza ambientale e un’Europa che rallenta la sua crescita frenata dalla locomotiva tedesca, chiamati a definire con una parola l’anno che stiamo vivendo, il 40% degli italiani sceglie il termine “preoccupazione”, il 25% opta per “insicurezza” e il 21% chiama in causa “inquietudine”. Contemporaneamente, in nome di un atavico spirito di adattamento, c’è anche chi usa la parola “curiosità” (28%) e si spinge fino alla “fiducia” (23%) e addirittura “ottimismo” (22%). L’Italia appare un Paese diviso e dalle attese contrastanti in cui coloro che esprimono aspettative in qualche modo positive per il 2025 raggiungono appena il 52% superando solo di misura coloro che invece guardano con tinte fosche ai prossimi mesi. Tra questi ultimi in prevalenza le donne, i baby boomers e naturalmente la lower class, come i sondaggisti chiamano i redditi bassi da lavoro e pensione, il piccoli commercianti, i precari che in un paese come il nostro sono ormai in numero considerevole. Un clima sociale certamente più grigio rispetto anche solo di un anno fa quando prevalevano maggiormente sentimenti di serenità e accettazione (queste le parole associate per la maggioranza al 2024). A pesare sulle percezioni sono sicuramente il contesto internazionale e le difficoltà economiche del sistema Paese. Preoccupano soprattutto le guerre e i conflitti (81%), le tensioni geopolitiche (76%) e i cambiamenti climatici (71%). Ad alimentare la positività viceversa continuano ad essere soprattutto gli affetti familiari (69%), la salute fisica (59%) e il benessere psichico (56%). In questo contesto i manager italiani intervistati ipotizzano per i prossimi 12 mesi un ulteriore rallentamento del Paese che sembra nuovamente perdere il passo della – pur già lenta – economia europea. Per gli opinion leader la crescita italiana del Pil potrebbe fermarsi nel 2025 appena sopra lo zero (+0,5%, a fronte di una previsione Istat di +0,8%), con una Unione europea che per il 60% degli intervistati è destinata ad indebolirsi. Incerti e preoccupati per quanto potrà accadere prossimi dodici mesi, certo consapevoli che le loro azioni poco potranno incidere sulle grandi vicende globali, gli italiani si acconciano a questa nuova realtà e ripiegano su sé stessi e sul loro privato. La famiglia è così al centro dei propri desiderata per l’anno appena iniziato (stare di più con la famiglia è il progetto indicato dal 75% degli intervistati con un +25% rispetto all’anno precedente) e la tranquillità e l’armonia gli obiettivi da raggiungere (per il 25%), senza però dimenticare il successo e la realizzazione di sé scelti dal 16%. Propositi più o meno trasversali a tutte le età, anche a costo di rinunciare nel 2025 a valori come generosità e altruismo che pur ci avevano guidato nell’anno appena trascorso (-8% degli italiani dichiara questi riferimenti valoriali da un anno all’altro). Insomma, in prospettiva, gli italiani vogliono diventare più individualisti ed ego referenziali, (nemmeno l’integrità e gli ideali se la passano troppo bene e perdono 5 punti percentuali dal 2024 al 2025) e conseguentemente intenti a curare la propria dimensione personale. In vetta alle tendenze in crescita nel nuovo anno, troviamo oltre al classico andare di più a piedi, anche fare sport e attività fisica, realizzare escursioni nella natura e leggere più spesso libri e riviste. Una vita più zen in sostanza. Anche se molti dei desiderata rimangono tali come l’idea di trasferirsi in un’altra città o all’estero, mettersi in proprio o riprendere gli studi. Questa ricorrente – e forse quasi ossessiva – attenzione alla propria dimensione personale sembra associarsi ad un atteggiamento rinunciatario verso una più solida prospettiva futura. Per impossibilità – e in qualche caso anche per scelta – gli italiani sembrano prigionieri del loro presente, e rinunciano sì a comprare la casa o anche solo l’auto, a cambiare lavoro o città, ma anche a sposarsi e mettere al mondo un figlio. Le intenzioni di nuove unioni o nuova genitorialità sono nei programmi di solo il 6% degli intervistati e stessa percentuale per coloro che pensano di sposarsi (4% tra i 18-29enni). Un qui e ora molto pragmatico, una sorta di antidoto contro la preoccupazione. Il fatto è che se questi problemi riguardano un po’ tutti e non è credibile che ognuno li possa risolvere da solo. Parlarne aiuta a diluire il peso, perché essere in difficoltà non è una colpa, è una conseguenza delle difficoltà generali. Socializzare, cioè parlarne, discuterne, affrontare i problemi che solo apparentemente sono individuali è il vero modo per trovare soluzioni collettive.
Che fatica essere giovani
Sono stati pubblicati i dati di un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore da cui si ricava che le cose non vanno molto bene
Il campione usato è fatto di mille giovani tra i 16 e i 24 anni, dunque studenti o lavoratori alle prime esperienze. Uno su due indica tra i fattori che più influenza il proprio futuro la crisi economica (49%) e il lavoro (47%), due nodi che vengono considerati più impattanti sulla sfera personale di sicurezza, immigrazione e guerre. L’81% degli intervistati ritiene che il malessere psicologico sia una condizione diffusa. Ben il 70% ha affermato di essersi sentito depresso o senza speranza negli ultimi 12 mesi, un giovane su cinque riferisce di trovarsi in questo stato quasi tutti i giorni. Solo il 7% dei giovani ha detto di non essersi mai sentito in questo stato. Questo disagio non viene tuttavia affrontato rivolgendosi a un professionista: il 42% del campione non ha mai parlato con uno psicologo, o non pensa proprio di averne bisogno. Il 40% degli intervistati, se anche ne ha sentito la necessità, non ne ha mai contattato uno, e questo solleva pesanti dubbi su quanto ciò possa essere dovuto anche a motivi economici. Un giovane su cinque si sente escluso dalla società, e più di uno su due oscilla tra inclusione ed esclusione. Il 55% delle persone segnala la perdita di interesse nei confronti della vita sociale e di relazione, il 52% dei rapporti scolastici e lavorativi. Si salva leggermente la sfera familiare, fermandosi al 46%. Il 93% degli intervistati dichiara di non essere impegnato in politica, l’80% non partecipa ad attività di volontariato. Il 52% dei giovani afferma che, ora come ora, non andrebbe a votare. Tolto il 17% degli intervistati che trascorre il tempo sui social, il 25% guarda la tv, il 23% ascolta la musica. Il 14% legge e studia. Ce n’è di lavoro da fare per chi si occupa del sociale sul territorio.
Paese che vai, marciapiedi che (non) trovi
Il dibattito sulla carenza di marciapiedi a Sacrofano, problema sollevato da Lorenzo Bandinelli nel numero scorso: pubblichiamo due interventi. ‘L’assenza di marciapiedi a Sacrofano ostacola la coesione sociale’ questo articolo ha centrato il mio interesse. Vieppiù che progredisce questo nostro territorio mi fa meraviglia la indifferenza delle Amministrazioni Comunali e degli abitanti per l’assenza di marciapiedi lungo queste nostre strade del tutto assenti anche nelle zone della nuova espansione edilizia. Se non capissimo di cosa si tratta, proviamo con un esempio pratico, la via di Santa Maria: «Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente». Seppure, chi ci abita, si sarà adattato alla condizione da suburra di questo recente pezzo di città: fateci camminare una mamma col passeggino a portare il figlio all’asilo, o fate uscire dal cancello un bambino per andare a giocare col compagno, o passeggiare stretti due fidanzatini: tra le macchine che salgono e scendono nei due versi di marcia a slalom tra quelle parcheggiate e tra i potenti muraglioni a presidio dei confini debordanti di frasche, beh! solo santa Pupa li potrà preservare da ogni male. Quante strade trovate in condizioni più civili a Sacrofano? Forse sarà meglio a zona Marini o forse a via Canneto, etc. etc.? Che ci possiamo fare, se le cose sono sempre state fatte male, nonostante le Regole? Ovvio che noi cittadini assumiamo comportamenti di autodifesa: si esce solo in macchina, guai andare a piedi, attenti! Intanto bisogna superare le consuete obbiezioni: ognuno vuole il suo passo carrabile, ma sapete che il Comune di Sacrofano non s’è mai premurato di autorizzarne alcuno? Poi, bella pretesa quella di occupazione abusiva del suolo pubblico da parte dei negozianti. Infine, sfatiamo la favola che lungo le Provinciali non abbiamo competenza: perché saranno abusivi tutti quei chilometri di marciapiedi, che vediamo costruire in ognuno dei paesi qui intorno; ci svergognano. Non funziona la condanna dei tempi moderni contro il bel tempo antico. Invece ci possiamo permettere almeno di pensare positivo, desiderare, immaginare. Da dove cominciamo? Qual è il tratto di marciapiede più urgente per la gente di Sacrofano? Dai parliamone! Comincio io: un marciapiede dal fondo di via dello Stadio fino al bivio di Santa Maria, un altro nel tratto in fondo di Monte Caminetto fino al ponticello. Dai, tocca a voi. Ma l’avete vista quell’amazzone che è venuta da Marte a marciare sui cigli della provinciale da Monte Caminetto al paese, sfidando camion e pullman? Non sarà mica peccato immaginare un bel viale alberato lungo il rettilineo della Strada Romana Dritta! Guardate che lì non sarebbe così diffcile, perché è ancora preservato il distacco regolamentare dei tre metri tra la strada e le recinzioni originarie previste della riforma agraria dell’Ente Maremma. Ma ve lo potete immaginare il facile prolungamento di questo nuovo viale alberato pedonale passante per il bivio di Borgo Pineto fino a congiungersi con il rettilineo di Monte Caminetto? Chi obiettasse, sappia che quel tracciato è già disposto da 45 anni dal Piano Regolatore Comunale, alla faccia di tutti i Sindaci succedutisi. Osiamo: un moderno vialone pedonale e alberato da Monte Caminetto o a Piane Pozza sarebbe un trofeo per “La Nuova Sacrofano” e per Sacrofano un’eccellenza metropolitana, ci verrebbero da tutta Roma. (Antonio Marini).
Mi riallaccio all’articolo sui marciapiedi del precedente numero, a firma L.B. I marciapiedi sono una risorsa perché favoriscono chi vuole andare a piedi e lasciare la macchina, procurando molto più rispetto per l’ambiente e ben-essere per sé stessi. C’è inoltre una sicurezza maggiore per i pedoni avendo a disposizione uno spazio riservato, considerando che ci sono diverse persone che camminano o corrono lungo la provinciale. Poi siamo in campagna, riattiviamo le buone abitudini di una volta, ripristiniamo passaggi e sentieri. Personalmente ho fatto delle passeggiate partendo da Sacrofano Centro storico e attraverso un sentiero dell’Ente Parco che passa nei nostri boschi, sono scesa sulla via Formellese dove con un marciapiede comodo sono giunta al Centro storico di Formello. Era il percorso utilizzato tanti anni fa dagli abitanti che per spostarsi andavano a piedi. Di Borgo in Borgo. Sono disponibile a parlare di questo tema per trovare delle soluzioni. (Stefania Culla).

Foto di Elio Cipriano